«Il latino insegna il senso del tempo e del silenzio»
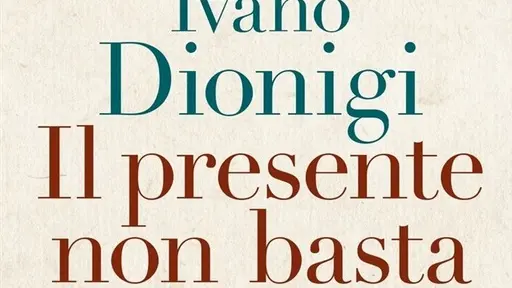
di Nicolò Menniti-Ippolito
Da qualche mese nelle classifiche dei libri più venduti accanto a gialli e bestseller internazionali hanno fatto la loro comparsa saggi dedicati al latino e al greco. Libri che esaltano la bellezza dell’ablativo assoluto o del duale, che mostrano quanto siano vive le lingue morte, che raccontano con entusiasmo quel mondo classico che sembrava essere stato messo nell’angolo. Molti si stupiscono, ma non Ivano Dionigi, uno dei maggiori latinisti italiani, per sei anni Rettore dell’Università di Bologna, autore proprio di uno di questi libri, “Il presente non basta. La lezione del latino”, che viene presentato domani a Padova.
Professor Dionigi, si discute se abbia ancora senso il Liceo Classico, se abbia senso insegnare latino e greco. Non la sorprende che poi i lettori comprino libri come il suo?
«No, per nulla. Quando a Bologna organizziamo il Maggio dei classici, tutte le altre iniziative si fermano, l’Aula Magna si riempie di 1500 persone, con tante altre collegate in streaming, ed è un pubblico di ventenni. Se invece parliamo di politica vengono cento persone e quasi tutte over sessanta. Non esiste crisi dei classici, semmai esiste la crisi dei classicisti. Mi viene da dire che miopi sono i nostri politici, non i cittadini».
Perché il presente non basta? Per molti il presente è totalmente autosufficiente. C'è proprio bisogno del passato?
«Sono molto contento che, da Cacciari a Napolitano, tutti coloro che hanno presentato il mio libro abbiano colto il suo carattere militante. Il pagliaio sta bruciando e non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro dal timbro estetizzante. C’è bisogno di restaurare la lingua, di recuperare il valore della parola nella Babele della comunicazione contemporanea. Non chiamiamo più le cose con il proprio nome, c’è assoluto bisogno di una ecologia della parola che ci riporti a connettere i nomi con le cose. Diciamo flessibilità per intendere disoccupazione, corridoio umanitario invece di dire intervento militare, ma nello stesso tempo invochiamo una trasparenza, che è solo cattiva coscienza. Il latino ci riporta alle parole, al loro valore autentico. Come dicevo oggi a lezione agli studenti, Occidente vuol dire tramonto e oggi noi stiamo tramontando. La lingua va rispettata, una civiltà si distrugge a colpi di parole, più ancora che con le bombe».
Nel suo libro dice anche che il latino ci insegna il tempo. In che senso?
«La rivoluzione digitale ha molti meriti, ma ha accelerato la dissoluzione del nostro rapporto col passato. Abbiamo staccato la spina con la storia, viviamo quello che Eliot chiamava “provincialismo di tempo”, pensiamo che il mondo nasca sempre qui e ora, che la sincronia esaurisca la realtà. Viviamo in spazi che sono diventati planetari, ma si è contratta la nostra dimensione del tempo. Questo produce dei giovani monchi, a cui manca una dimensione: abbiamo bisogno di fermarci per pensare, abbiamo bisogno di silenzio. Il latino ci restituisce la dimensione del tempo, ci restituisce il senso del silenzio».
Quindi ha ancora senso studiarlo, impararlo, tradurre, oppure la scuola potrebbe limitarsi a parlare dei classici latini e del loro pensiero?
«Se non si insegna la lingua, il latino a scuola non ha senso. L’accanimento grammaticale è assurdo, ma il latino rimane una palestra straordinaria perché ha la stessa natura degli esperimenti scientifici. Non sono io a dirlo. Quello che mi conforta è che a dirlo siano gli “infedeli”, gli scienziati. Lo dice un grande genetista come Cavalli Sforza, lo dice un fisico come Guido Tonelli: guai a eliminare il latino dalle scuole. Ed è per questo che vado volentieri nelle scuole. Mi accorgo che gli insegnanti in questo momento sono al fronte, hanno bisogno di conforto. Vorrei che si capisse che se l’Italia si riprenderà, e ci vorranno comunque molti anni, si riprenderà partendo dalla scuola».
Nel libro sono molto citati Seneca, Orazio, Lucrezio. Ma esiste un autore latino imprescindibile?
«Se dovessi dire quale classico è centrale nel terzo millennio, risponderei Seneca. Non per le tragedie, non per i suoi interessi scientifici, non per i suoi contenuti, ma per la lingua, per il “come”. Seneca ha preso una lingua povera, una lingua di agricoltori, e l’ha trasformata in una lingua della interiorità, quella che poi hanno usato tutti, da Agostino a Montaigne, per raccontare l’anima dell'uomo. Sarebbe anche, con le sue formule fulminanti, un grande titolista».
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








