Indagine su Elena Ferrante seguendo il filo delle parole
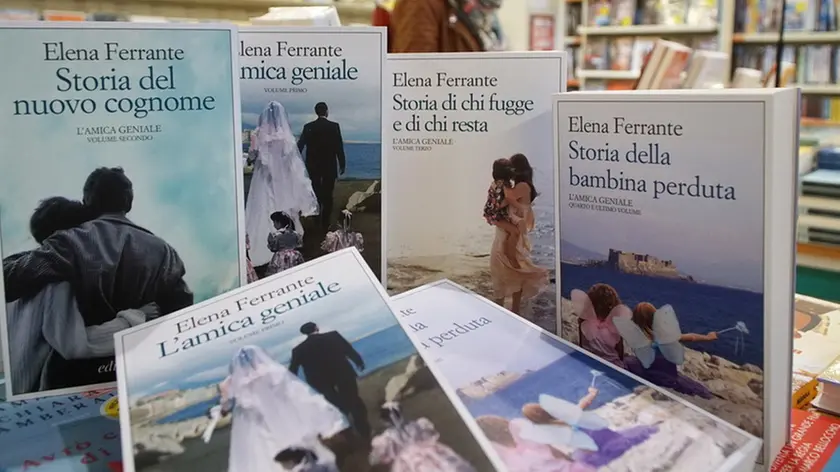
di MICHELE A. CORTELAZZO
L’inchiesta di Claudio Gatti, apparsa il 2 ottobre sul “Sole 24 Ore” e su alcune testate straniere, ha chiuso per sempre il “caso Elena Ferrante”, cioè il caso dell’identità dell’autrice di best-seller di diffusione mondiale? Gatti, dopo una serrata inchiesta giornalistica, ha portato attendibili indizi per ritenere che la percettrice dei diritti d’autore delle opere di Elena Ferrante sia Anita Raja, traduttrice e collaboratrice della stessa casa editrice che ne pubblica le opere (con un enorme incremento del proprio fatturato) e moglie di Domenico Starnone, a sua volta autore di romanzi, caratterizzati da affinità con le opere di Elena Ferrante.
Le prime reazioni hanno riguardato gli aspetti etici della vicenda. I fan di Elena Ferrante hanno ritenuto inaccettabile che un giornalista abbia frugato nei conti di una casa editrice, di una sua collaboratrice e del marito di quest’ultima, per cercare di ricostruire i flussi di denaro e il potere d’acquisto di queste persone. Si sono adottati metodi più adatti «a una inchiesta criminale che alla critica letteraria», ha dichiarato, tra gli altri, il poeta Adam Kirsch, e la stessa posizione ha assunto la casa editrice (che, per inciso, ha tenacemente difeso, con punte di malcelata stizza, la privacy dell’autrice, ma, con mio sommo stupore, non ha detto una parola sullo spionaggio aziendale di cui è stata vittima).
E poi, resta la questione centrale: è importante conoscere l’identità dell’autrice fino a ieri sconosciuta, o hanno ragione i lettori che si indignano per questo interesse che esula dalla considerazione della bontà letteraria (per alcuni, a dire il vero, sopravvalutata) dei romanzi? Al punto che, qualcuno, ha dichiarato che avrebbe preferito non sapere, un po’ come i bambini quando scoprono che Babbo Natale non esiste.
Ma davvero sappiamo? Le scoperte di Gatti hanno svelato il mistero una volta per sempre? Io credo di no. Come ha scritto Giulio Mozzi su Facebook: «Nulla sappiamo di Elena Ferrante, se non il nome dei prestanome che ne hanno gestiti i guadagni editoriali. E dunque?».
E dunque, restano i problemi posti dai testi. Il primo riguarda il ruolo di Domenico Starnone nella scrittura dei romanzi attribuiti alla moglie. Non si può dimenticare che esistono analogie tematiche tra i primi libri di Elena Ferrante e quelli di Domenico Starnone. Non si può dimenticare che nel 2005 un fisico dell’Università “La Sapienza” di Roma, Vittorio Loreto, aveva confrontato, con metodi matematici, i romanzi di Elena Ferrante con altri romanzi, verificando l’esistenza di una forte affinità tra Ferrante e Starnone.
Non si può nemmeno dimenticare che nei mesi scorsi una statistica dell’Università di Padova, Arjuna Tuzzi, ha confrontato, questa volta con diversi metodi statistici, un centinaio di romanzi scritti nell’ultimo trentennio, e anche in questo caso è sempre risultata una netta vicinanza tra i romanzi di Elena Ferrante e quelli di Domenico Starnone.
A partire da questi risultati, io stesso ho iniziato a valutare se ci sono similarità linguistiche tra la lingua di Elena Fer. rante e quella di altri autori italiani degli ultimi anni (ho esaminato 230 romanzi). La ricerca è in corso, ma stanno emergendo numerose tracce, relative a un significativo manipolo di parole, che avvicinano il lessico di Elena Ferrante a quello di Starnone. Faccio un solo piccolo esempio: malodore è parola relativamente frequente in Elena Ferrante. Esiste anche una variante maleodore che si riscontra ripetutamente in Francesco Piccolo; ma la forma malodore compare solo nei romanzi di Ferrante e Starnone. È una semplice coincidenza? È una questione di lessico familiare, che dalle mura di casa si trasferisce nei romanzi di Ferrante-Raja e in quelli di Starnone? O è un indizio che Elena Ferrante non è un individuo, ma un’impresa a conduzione familiare e che, almeno nella scrittura finale, c’è lo zampino del marito?
Sicuramente la spiegazione che ha offerto Claudio Gatti, preoccupato che le ricerche di Loreto potessero scalfire l’impianto della sua inchiesta, e cioè che le similarità tra Ferrante-Raja e Starnone si possano motivare con un comune modello, e che questo modello sia Christa Wolf, fa semplicemente sorridere, quando le somiglianze si materializzano in parole dell’italiano regionale campano.
Ma a nutrire dubbi è anche Marco Santagata, l’italianista dell’Università di Pisa, che in marzo aveva creduto di riconoscere Elena Ferrante in Marcella Marmo: nel “Corriere della Sera” del 6 ottobre, Paolo Di Stefano ha dato voce ai dubbi di quanti percepiscono uno scarto stilistico tra i primi due romanzi di Elena Ferrante. Santagata ha rilanciato ipotizzando che «oltre a Raja e Starnone, ci siano forme di collaborazione, difficili da definire, tra più persone». Insomma, non un’impresa a conduzione familiare, ma una piccola o grande cooperativa.
«L’indagine di Gatti secondo me non è risolutiva», afferma Santagata. A mia volta, mi dichiaro d’accordo con Elena Ferrante che una volta, intervistata ha detto, anzi ha scritto: «fuori dei testi e delle loro strategie espressive c’è solo chiacchiera». Ma sono proprio i testi, e le parole di cui sono fatti, che continuano a porre domande che meritano un tentativo di risposta.
Poi, qualcuno trova che si tratti di domande morbose, la cui soluzione non aggiunge o toglie nulla all’esperienza e alla conoscenza degli appassionati di Elena Ferrante?
Nessuno lo obbliga a leggere i dubbi, le ipotesi, i risultati delle ricerche. Ma lasci che altri possano interessarsi a questi aspetti. E magari anche ad entusiasmarsene. In fin dei conti, davanti a una cometa c’è chi guarda estasiato il cielo, chi narra il bellissimo racconto dei saggi che vanno a omaggiare un bambino che cambierà la storia dell’umanità, chi ne traccia l’orbita e chi manda la sonda Rosetta a capire di più della materialità di questi corpi celesti.
Permettete, con spirito tollerante, questa pluralità di atteggiamenti anche a chi si occupa di testi e di letteratura.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








