Il mondo dell’arte piange Puppi, storico e studioso appassionato
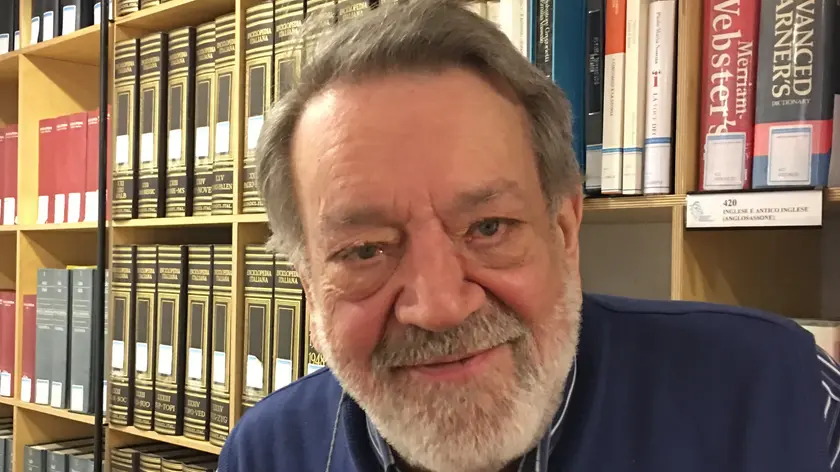
VENEZIA. Con Lionello Puppi scompare un grande maestro della storia dell’arte italiana degli ultimi sessant’anni. Si era laureato a Padova con il bizantinista Sergio Bettini, con una tesi sul pittore vicentino Bartolomeo Montagna: fino a pochi anni fa era l’unica monografia disponibile sul tema. Era un lavoro di impianto filologico: il classico “Catalogo ragionato” ben comprensibile nella cultura della connoisseurship della Padova di Giuseppe Fiocco e Rodolfo Pallucchini.
Puppi iniziò così, studiando la grande pittura del Rinascimento veneto. Ben presto, però, spostò l’attenzione su una disciplina all’epoca di nicchia: la storia dell’architettura. Lo fece inseguendo – e fu per una intera vita – il profilo altissimo e per certi versi inafferrabile di Andrea Palladio. Gli dedicò saggi densissimi, monografie condotte con implacabile rigore e anche alcun testi divulgativi, che si divertì molto a scrivere, forse anche memore della lezione di uno dei sui più cari amici: l’editore e scrittore Neri Pozza. Ponendosi sulle tracce di Palladio, e di decine di altri architetti meno celebri che componevano la galassia del palladianesimo, si trovò nella condizione di affinare i suoi strumenti di ricerca archivistica e documentaria, che lo aiutarono a superare la prima fase, per così dire, di approccio essenzialmente formale al prodotto artistico. S’aggrappò ai documenti – inediti o riletti attentamente – per reimpostare le decine, centinaia, migliaia di problemi critici in cui si imbatteva. Privilegiandoli rispetto alle intuizioni “attributive”, provò a utilizzarli come strutture portanti di un’interpretazione dell’opera d’arte che fosse di natura prettamente storica, ricondotta cioè nell’alveo di un approccio quasi neopositivistico. Neppure questo gli bastò. Si appassionò alle letture di uno dei padri della cosiddetta iconologia: il tedesco Erwin Panofsky. L’iconologia è quella branca della storia dell’arte che, partendo dalle immagini, tenta di coglierne il significato più profondo.
Il significato, il senso, la ragione di un’opera tende sempre a sfuggire, anche agli esegeti più accaniti (anzi, soprattutto a loro, avrebbe chiosato Puppi): a un nuovo elemento di comprensione, ne seguono infatti altri cento che sfuggono. Al pari di un suo caro compagno di indagini – Eugenio Battisti – cercò dunque di attaccare il fortino (quasi) inespugnabile del mistero insito nella creazione artistica, considerandola come espressione di un insieme di relazioni, che si pongono all’interno di flussi storici più generali, in cui ogni aspetto si lega – o si può legare – a tutti gli altri. Ad esempio. Quando mise in piedi un progetto per le celebrazioni della quarta nascita di Giorgione nel 1978, per cercare di inquadrare il profilo del più sfuggente tra i pittori del Rinascimento, convocò esperti delle più diverse discipline: non sono storici dell’arte, ma anche archeologi, numismatici, filosofi, musicologi, cartografi, storici dell’editoria, della medicina, della scienza, dell’economia, dell’urbanistica … Cercò così di proporre una visione diversa non dell’artista, ma del contesto culturale di cui era espressione. Fu un’impresa di indicibile arditezza, che doveva surrogare una mostra quasi impossibile e il cui catalogo – anche per le difficoltà di miscelare tutti quei contributi – uscì ben 16 anni dopo l’evento, a cura di un suo fedele collaboratore, Ruggero Maschio. Dopo quella organizzò molte altre mostre, a Padova, Venezia, Belluno, Treviso. Le mostre erano per lui un laboratorio di ricerca, in cui chiamava a lavorarci figure molto diverse tra loro. Soprattutto si circondava di allievi: che erano tantissimi, perché lui una tesi non la rifiutava a nessuno. Dai primi anni Settanta insegnava a Padova, dove diresse l’Istituto di Storia dell’arte e dove decise di inaugurare la cattedra di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica. Poi passò a Venezia, a Ca’ Foscari, dove si assunse l’onere di dar vita a un Corso di Laurea in Conservazione dei Beni culturali. A Udine già esisteva, ma Venezia era la sede perfetta. Nei primi anni non era però previsto alcun finanziamento ministeriale e lui – comunista fino al midollo – si ritrovò a cercar di racimolare qualche soldo chiedendo nientemeno che a Marcello dell’Utri. Per far decollare quel corso avrebbe fatto patti col diavolo: ma non servì, perché la sua straordinaria capacità relazionale – era figlio di un diplomatico di nobili origini – unita a un certo fascino del rischio, gli consentì di realizzare le condizioni necessarie per quel dono alla città.
Le sue lezioni erano sui temi più disparati – dal medioevo al contemporaneo, dall’America del Sud all’intero bacino del Mediterraneo – ed erano il frutto di una curiosità onnivora e inesauribile. La ricerca della verità lo tenne lucidissimo fino all’ultimo. Porta con sé un tesoro di ricordi, informazioni ed esperienze di inestimabile valore. Lascia molti allievi sulle cattedre delle Università, nelle Soprintendenze e nei Musei, ai quali ha insegnato moltissime cose. Le più importanti furono il coraggio e la generosità intellettuale. —
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








