La lunga storia di un piccolo fiore
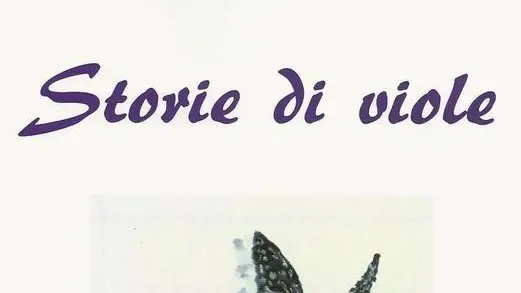
Ne hanno scritto più i letterati che i botanici. E Chiara Saccavini, che è questo e anche quello, ha dedicato loro un intero libro: “Storie di viole”. Dieci capitoli fitti come un ordito di sapienza botanica sul quale ha tessuto un’appassionante trama di fatta di esoterismo, astrologia, religioni, psicologia, arte, musica e letteratura. E tutto questo su (e per) un fiorellino poco appariscente, che come pochi ha saputo essere al centro di una singolare stratificazione di storie, leggende e miti. “Come un piccolo fiore può influenzare il mondo” è l’appropriato sottotitolo di questo volume in cui l’autrice (che gestisce l’azienda vivaistica di famiglia a Martignacco di Udine), svela millenari intrecci che fanno dell’umile viola un esempio di resistenza «a mode che cambiano, costumi che si evolvono, lirismi che si rarefanno».
Così Saccavini ci ricorda Teofrasto e ci avvisa che le violette erano già in vendita nei mercati di Atene nel 400 a.C. (erano usate per incoronare le effigi di Afrodite e imbandire le tavole dei banchetti) e che nell’antica Roma si celebravano i “Dies violae”, ogni 22 marzo, e nei giardini non mancava mai un Violarium. E che Plinio consiglia di consumarle con fette di limone e arancia, mentre già prima di lui i persiani le usavano per profumati sorbetti. Ma anche che la viola ha fatto scoprire, fin dall’antichità, le sue capacità depurative e antinfiammatorie; che i guerrieri nomadi delle steppe ne facevano un amuleto contro i nemici; che per l’antroposofia rappresenta una specifica classe vegetale e incarna il punto d’incontro tra mondo animale e vegetale.
Tra le pagine (delicatamente illustrate da Massimo Scifoni), scopriamo anche la passione per le violette di Napoleone (curiosamente corrisposta sia da Giuseppina, sia dalla seconda moglie, Maria Luigia d’Austria, che ne diffuse la coltivazione a Parma dopo averne assunto il ducato) e di altre teste coronate come la regina Vittoria, ed è ricco e articolato l’elenco di quello che Saccavini definisce “il delirio di rappresentazioni delle viole” nell’arte a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Ma quel che sembra essere il motivo conduttore e anche propulsore di tutte le storie raccolte è soprattutto una sorta di “indipendenza” della viola. Infatti, mentre l’uomo da sempre ne seleziona varietà per assecondare mode passeggere, lei (che si riproduce sia sessualmente sia vegetativamente) si auto-rinnova in forme sempre diverse, tanto che la sua coltivazione industriale non è gestibile ed è difficile persino la sua classificazione, proprio perché ha alcuni caratteri distintivi mutevoli. E proprio grazie a questa sua capacità la viola (ma sarebbe opportuno dire “le viole”, poiché ne esistono circa 400 specie) si ambienta ovunque. Supera ogni difficoltà, diffondendo umile bellezza e ferma resistenza, simbolo di un mondo vegetale che a dispetto di tutte le insidie e le costruzioni (più umane che naturali) continua a purificare l’aria e anche l’anima. E del quale Saccavini sa raccontare, con piglio poetico e passione botanica, in modo avvincente i prodigi.
Chiara Saccavini: “Storie di viole - Come un piccolo fiore può influenzare il mondo”. Edizioni youcanprint, 2014.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








