«Lontani dal Palazzo per difendere i deboli»
Padre Paolo Bizzeti e la svolta dei Gesuiti
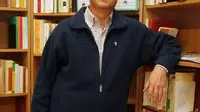
C’è stato un tempo, a Padova, nel quale i gesuiti erano gli educatori della classe dirigente, i consiglieri del principe, i custodi dei valori dominanti. Erano numerosi e potenti e l’abbinata Antonianum-Petrarca rappresentava un bastione del potere politico-finanziario in città e un viatico ai salotti buoni. Oggi, chi osserva la Compagnia di Gesù scorge un drappello di preti lontani dal Palazzo, più sensibili alla filosofia che alla politica, intenti a predicare il Vangelo senza distinzione di persone. Anzi, con un occhio di riguardo a immigrati, detenuti, prostitute, malati.
Non proprio l’élite, almeno nella concezione borghese della dialettica sociale...
«Ecco, mi sembra che circolino due valutazioni della presenza gesuita a Padova. Quelli che ci hanno conosciuti nell’epoca gloriosa dell’Antonianum, forse il più importante luogo educativo di questa città, sognano una rinascita, ammirano il passato della Compagnia e sperano che ritorni protagonista. Poi ci sono i delusi, che si sentono traditi e prendono le distanze. Ci vedono come una navicella in disarmo, ci considerano una realtà finita. Da parte mia, trovo che entrambe queste visioni contengano sia elementi di verità che forzature».
Eppure il declino dell’influenza gesuita appare evidente.
«Io credo che nel recente passato la Compagnia abbia compiuto azioni importanti, persino gloriose, ma non senza limiti dal punto di vista evangelico. Un gruppo influente dal punto di vista culturale, significativo dal punto di vista economico, e non privo di una sua visibilità. Allora, tutte le porte si aprivano perché gli uomini importanti erano stati formati alla nostra scuola. Ma ciò rendeva la Compagnia poco profetica, scarsamente critica e in parte condizionata. Ciò vale per Padova e molti altri luoghi del mondo. Mezzi, uomini, prestigio, autorità... Che tutto questo fosse in linea con il Vangelo, beh, è vero solo in parte. Nella realtà, eravamo schierati con una parte della società, anche se sempre abbiamo sensibilizzato all’aiuto alla povera gente».
Un mea culpa che ricorda le battute conclusive del film «Mission». Cosa vi ha indotto a cambiare rotta?
«Il Concilio, la crisi della vita religiosa, la sfida della nuova evangelizzazione, la riscoperta del cammino dei primi padri gesuiti, la riflessione sulla vita e sul pensiero di Sant’Ignazio. Ci siamo resi conto, non senza sofferenza, che la Compagnia aveva sì meriti evidenti, ma doveva anche tornare all’ispirazione originaria dei primi compagni di sant’Ignazio che avevano scelto un annuncio del Vangelo a tutto campo, aiutando le persone a riconciliarsi e difendendo i poveri. Noi eravamo diventati i custodi della tradizione più che della novità del Vangelo».
Buon per voi che la Santa Inquisizione sia finita in soffitta.
«Se è per questo, Ignazio finì sette volte tra le grinfie degli inquisitori (ride ndr). La verità è che la Compagnia ha scelto di tornare alle origini: meno istituzionale, meno potente, meno preoccupata di avere visibilità. Più attenta al prossimo che a se stessa. La fine di un’epoca ha coinciso con una maggiore consapevolezza di voler essere i servitori della missione di Cristo».
Una svolta che per molti ha il volto e le parole di padre Pedro Arrupe, il “Papa nero” capace, negli anni Settanta, di rinnovare radicalmente la Compagnia secondo un disegno progressista non sempre gradito alle gerarchie vaticane.
«Le scelte di padre Arrupe sono state molto significative ma non dimentichiamo che già nella Roma del 1540 i gesuiti strappavano le prostitute agli aguzzini e aprivano mense popolari insieme ai laici».
Sarà, ma in occasione del vostro recente “conclave” l’inviato pontificio non ha mancato di richiamarvi all’obbedienza verso il magistero. Siete così ribelli?
«Non direi, visto che abbiamo un quarto voto speciale, quello dell’obbedienza al Papa che anche negli anni recenti ha portato molti gesuiti a lasciare quanto stavano facendo per andare dove il Papa chiedeva. Solo che non si tratta di un’obbedienza astratta e acritica. E’ piuttosto l’adesione convinta alle missioni che ci vengono assegnate, a prescindere dai nostri personali desideri. E’ un voto che abbiamo rispettato con il sangue dei nostri martiri: 134 nella sola America latina. Inoltre il Papa, nell’udienza del 21 febbraio con i padri del “conclave”, ha esattamente chiesto ai gesuiti di muoversi secondo questo modo di vedere la missione, citando proprio padre Arrupe».
Torniamo a Padova. Chi siete e cosa intendete fare?
«Siamo una trentina, tra padri educatori e giovani in formazione, italiani e stranieri. Chi ci sta intorno vede una realtà piccola, sì, che però ha un sapore davvero evangelico perché qui è possibile trovare un modo di essere Chiesa libero e liberante, vicino alle persone. Per alcuni anni a Padova la Compagnia ha perso tempo, non lo nego; ma è anche difficile ricercare qualcosa di sensato e di sostenibile per il futuro. Ora ciò vogliamo fare è un piccolo centro di formazione per i gesuiti che studiano filosofia. Non sarà una grande accademia, ma un luogo di cultura globale per crescere come uomini e come apostoli. Non è tutto. Ci rivolgiamo anche ai giovani e agli adulti del laicato: con la spiegazione della parola di Dio, l’aiuto a pregare, la solidarietà ai deboli e agli ultimi. Insomma, non puntiamo a riesumare il passato, vogliamo fare qualcosa di nuovo, modesto ma significativo».
Cosa sorgerà in Prato della Valle sulle ceneri dell’Antonianum?
«Lo definirei un piccolo arcipelago: centro giovanile, istituto filosofico, abitazioni per docenti e studenti, e un auditorium aperto alla città. Il progetto l’abbiamo presentato circa un anno fa, speriamo che presto si arrivi all’approvazione, almeno delle linee guida. Sarete i primi a saperlo».
Questa è la città del Santo e di Giotto ma la sua raffigurazione mediatica è diventata tutt’uno con la triade sesso-muri-droga. Come si muove un gesuita qui?
«Padova mi sembra ricca, ricca di denaro, intendo. Una città bella, dove traspare e trasuda il benessere. Personalmente, ciò mi piace e mi spaventa. Apprezzo l’estetica dei palazsi e dell’arredo urbano, l’eleganza dei negozi, ma il Vangelo ci insegna che gli uomini, quando stanno troppo bene, tendono a costruire delle cittadelle impenetrabili e chiudono la porta ai loro fratelli meno fortunati, alle nuove povertà. Sì, penso ai servi della gleba del nostro tempo, penso ai tanti ragazzi che passano ore e ore con un bicchiere in mano: nulla di drammatico, in sé, ma certo poco costruttivo. E se l’alcol la fa da padrone, allora ciò che rimane è una piazza malridotta. Ci trovo un vuoto di senso preoccupante, è la noia di vivere che mi fa paura».
Il benessere è una colpa?
«Senz’altro no, ma una certa egemonia del denaro e del consumo umilia chi non riesce a raggiungere un elevato livello economico. L’onestà, l’apertura intelelttuale, la ricerca del bene comune e del volto di Dio... sembrano offuscati dall’individualismo e dal consumismo. E altrove le relazioni per chi arriva da fuori, e non mi riferisco ai migranti ma anche ai professionisti, sono più agevoli. Ma non è questo a colpirmi di più».
A cosa si riferisce?
«Mi sorprende che certi fenomeni, penso al mercato del sesso e della droga, si svolgano in un’apparente cornice di rispettabilità. Mi turba il fatto che vi siano persone che la domenica vanno in chiesa ad ascoltare la parola di Dio e il lunedì assumono i peggiori atteggiamenti. Come se farsi paladini dei valori della cristianità e nel contempo inneggiare alla xenofobia, fosse la cosa più naturale del mondo. Ecco, tradizione ecclesiale e intransigenza a volte qualunquista: non vede questo pericolo?».
Lo confessi, voi gesuiti avete un’indole ambigua.
«No, siamo delle persone critiche. Non ci piacciono le scorciatoie né le semplificazioni. Non condividiamo certi modi di essere chiesa e certi metodi della classe dirigente, diffidiamo dei piagnistei e del pauperismo. Non accettiamo una cultura che vorrebbe autocertificarsi come l’unica. Noi coltiviamo il rispetto per la complessità e le banalizzazioni da spot pubblicitario non ci convincono. Perciò la nostra vita non è semplice: andiamo a braccetto con tutti ma non sposiamo nessuno. Come Gesù, che andava a cena con gli uomini devoti ma anche con il pubblicano Matteo».
Come vanno i vostri contatti con la classe dirigente padovana? Una volta, nelle stanze dei bottoni, entravate dalla porta principale.
«Noi conosciamo delle persone importanti ma non ci piacciono le alleanze non orientate alla ricerca di relazioni più giuste in senso ampio. Parliamo a tutti, senza discriminazioni di ceto o cultura, ma vogliamo restare liberi, rinunciando agli sponsor e alle protezioni del passato, se non basate su orizzonti e valori condivisi. Forse non siamo più in fascia alta. Pazienza. Manteniamo la nostra visione critica dei gruppi di potere che fanno quadrato e non accettano di essere posti in discussione. Staremo insieme a quelli con i quali nessuno vuole stare, soprattutto con le persone che si trovano a drammatico confronto con il dolore. Tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti con questa realtà».
Il pensiero borghese e liberista, e le sue numerose subculture, sembrano senza rivali.
«Usciti dalla strettoia marxismo-capitalismo, è iniziata la ricerca di una via diversa e alternativa, che ancora non ha dato esito. Noi scorgiamo i limiti di questo “pensiero unico” e crediamo che l’economia debba essere al servizio non di pochi ma del maggior numero possibile di persone. La globalizzazione, per essere accettabile, deve servire l’uomo, non asservirlo».
Parole da No Global.
«No, noi non siamo rivoluzionari, ci sforziamo di essere apostoli del Vangelo. Semmai, la storia ci insegna che chi segue la parola di Gesù, inevitabilmente subisce un processo di emarginazione da parte dei poteri forti: politici, economici e anche religiosi. Vede, il ritorno al Vangelo non è una mania di chi vuole difendere a tutti i costi l’eredità del Vaticano II. E’ qualcosa di utile per tutti, perché l’amore e l’insegnamento di Gesù di Nazareth sono un riferimento prezioso per la vita e la civiltà. E questo non è scontato. C’è molta gente, anche tra quella che va in chiesa, che il Vangelo l’ha dimenticato in un cassetto».
Per concludere, in città le logge massoniche crescono in modo speculare al vostro regresso. Brutto colpo eh?
«Già, a Padova la massoneria c’è e si fa sentire, a quanto si dice. Noi diciamo solo che laddove un gruppo tende a farsi totalizzante, allora entra in rotta di collisione con chi ha come punti di riferimento la Bibbia e la Chiesa. Ci siamo sempre opposti ai massoni in nome di questo principio».
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova
Leggi anche
Video








