Dialetto dolente di Cecchinel
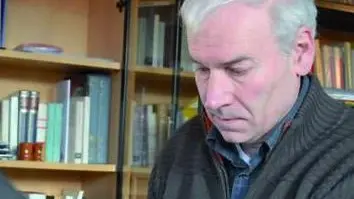
Se partendo dalla casa di Andrea Zanzotto si risale lungo il corso del Soligo, fino all’estremo limite della provincia di Treviso verso Belluno, si arriva a Revine Lago dove il dialetto si fa più aspro, più rustico. Ed in questo dialetto ha scritto la maggior parte dei suoi versi Luciano Cecchinel, il poeta che Andrea Zanzotto ha sempre indicato come suo erede. Eredità pesante, fin troppo ingombrante per un poeta totalmente appartato, che ha cominciato a pubblicare tardi ed ha centellinato in tutta una manciata di poesie con lunghi silenzi a fare da sfondo. Lo stesso Cecchinel, che pure di Zanzotto è stato amico ed in qualche modo anche allievo, ha spesso declinato imbarazzato la designazione ad erede, ma, con l’ironia che qualche volta tirava fuori, Zanzotto diceva che guardandosi intorno non vedeva altri. Ecco perché Sanjiut de stran (Marsilio, p.159, 12.50 euro) è un libro importante, anche se probabilmente non destinato al grande pubblico, perché la poesia di Cecchinel non è certo di quelle facilmente accessibili, anche se lo stesso poeta accompagna i suoi versi dialettali con una raffinata traduzione in italiano. Ma è certo che sono le sonorità dialettali a fare la differenza, a costruire quell’espressionismo fonico che segnala nella sua prefazione Cesare Segre. Sì, perché la prefazione a questi versi è di un grande critico, che non ha paura di dire che «con Cecchinel siamo al livello più alto della poesia». E non solo. Il compito che Segre si assegna è quello «di celebrare la maestria» di un «grande artista, ma anche grande artefice». Sanjut de stran, insomma, vuole essere l’opera della consacrazione, a 64 anni, di Luciano Cecchinel, il suo passaggio da erede a maestro, in qualche modo. E’ un libro che viene dopo lunghi anni di silenzio, quasi di rifiuto per la poesia, ma è anche un libro che ha vissuto con Cecchinel tutta la vita, con alcune poesie scritte negli anni settanta e solo una dopo il 1998, anno di una cesura esistenziale, di una tragedia personale che lo ha portato a introdurre una parentesi di versi in italiano, con Lungo la traccia, pubblicato da Einaudi. Ma la centralità è quella del dialetto, è quella di parole cardine come “tragol”, la stradina ripida e profonda, come “zendadura” la spaccatura dolorosa della pelle, come “stran”, lo strame, come “sbrindolà” per dire fatto a brandelli. Ed in questa scelta c’è molto della sua poesia dolente ma senza nostalgie. Nell’unica poesia scritta dopo il 1998, “al zimitero”Cecchinel contrappone in due strofe il cimitero del paese di un tempo che “no l’era mai stat ciapà del tut da la mort” perché immerso nei boschi e nei prati coltivati, e quello di oggi che “l’è mael”, è solo, come abbattuto dai rovi e gli abbandoni che lo circondano. Perché ormai la natura è irrimediabilmente spezzata, come il castagno che muore nella prima poesia della raccolta, dicendo “son drio ‘ndar fardèi”, “son rivà a la me ponta/ a la me radis ultima”. O come il rantolo dell’ultima “anema che la ol restar viva”, quel “sanjut de stran patoc fin tel midol”, singhiozzo di strame fradicio fin nel midollo, che dona il titolo alla raccolta. Il il “sanjut” è comunque un segno di vita, una fedeltà a luoghi deturpati, abbandonati, traditi da tutti, meno lo “scodraz”, l’ultimo rimasto, il poeta che “pitost de domarse ’l se crèpa”, piuttosto che piegarsi si spezza.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








