ERMANNO OLMI «Il mio film è la guerra raccontata da Toni»
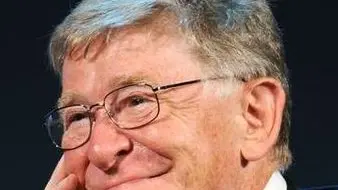
di Silvia Ferrari
ASIAGO (VICENZA)
L’altopiano di Asiago, quel bastione compatto che si distende tra Veneto e Trentino e che espande e apre lo sguardo della montagna, accoglierà il nuovo film di Ermanno Olmi dedicato alla Grande Guerra del 1915-18. «Il film si farà e si farà proprio qui, davanti casa», conferma Olmi. Quelle distese di prati e boschi che attraversano l’Altopiano, ferite profondamente dalle bombe e dalle trincee della Prima Guerra Mondiale, diventeranno dunque i luoghi d’elezione delle riprese e si ispireranno ai racconti di Toni Lunarda, un vecchio pastore narratore di storie che di quella guerra era stato protagonista. Sfuma dunque la minaccia di scippo da parte del Trentino che aveva provato a proporre il proprio territorio come scenografia per il film, facendo leva su una maggiore disponibilità economica. Le riprese dell’opera, proposta al comune asiaghese dalla società Ipotesi Cinema della figlia del regista, dovrebbero cominciare ad ottobre e, secondo le ultime indiscrezioni, il costo del film dovrebbe aggirarsi intorno ai 250mila euro.
Nell’attesa del nuovo film, Ermanno Olmi presenterà la propria autobiografia “L’apocalisse è un lieto fine”, edita da Rizzoli, domenica alle 17.30 al Palazzo del Turismo Millepini di Asiago. L’incontro è l’ultimo della rassegna “Aperitivo con l’autore”, organizzata dalla libreria Giunti al Punto di Asiago.
- Perché la scelta di raccontare un conflitto di cui lei non ha ricordi personali?
«Non è stata una mia scelta. Ma è stata l’occasione che mi ha fatto convinto di essere anch’io testimone non diretto di quella guerra, ma della celebrazione del centenario di quella guerra. A quella realtà sono legato non per vita direttamente vissuta, ma perché è un conflitto di cui ho sentito parlare. Quando ho fatto il film “Il mestiere delle armi” su Giovanni dalle Bande Nere, tra me e Giovanni erano passati cinquecento anni abbondanti. Però, nel momento in cui quegli accadimenti mi riguardano oggi, ecco che quel passato diventa uno specchio del presente. I racconti che ho sentito da mio padre, le cose che ho letto, le cose che ho visto al cinema mi aiutano a celebrare un accadimento che, proprio per la sua immane tragedia, ci ha lasciato comunque un insegnamento pagato con migliaia e migliaia di vittime. Questo riprendere oggi quella realtà trascorsa, anche solo per un film o un libro, dovrebbe farci domandare: che cosa abbiamo capito dopo quella prima guerra? Evidentemente poco o nulla se vent’anni dopo ne abbiamo fatta un’altra».
-La storia non è dunque maestra di vita?
«Guai se ci dimentichiamo che la storia è maestra di vita. Purtroppo lei è maestra di vita, siamo noi che non siamo i suoi discepoli».
-Quanto si comprende di questa guerra vivendo ad Asiago? Quanto è ancora presente questa ferita?
«Qui ogni volta che nell’orto rivoltiamo la terra si scoprono schegge e pallottole. E poi, al di là di questi reperti precisi che sono inconfondibili nella loro collocazione temporale e storica, verso il tramonto io ho visto ancora le tracce delle bombe, degli avvallamenti e di vecchi camminamenti di trinc. ea. Tutto questo adesso è stato coperto, come dice Shakespeare, “come da un velo pietoso”. Questa erba cresciuta sulla carne umana è un velo pietoso che ricopre questa realtà, ma al tempo stesso, se la guardiamo in controluce quando il sole è basso all’orizzonte, ci riporta tutto ciò che quella guerra ha rappresentato. Sia come grande dolore umano, sia come grande atto di umanità che quella guerra ancora aveva rispetto alle guerre attuali».
-L’umanità è ciò che la differenzia dalle guerre di oggi? Perché?
«Sì, allora tra i soldati esistevano ancora atti di pietà, solidarietà, comunanza. Oggi invece, sia nella vita quotidiana, sia nelle guerre, non ci si guarda più in faccia. L’uomo è solo un supporto per tecnologie distruttive. Costano di più le tecnologie che i soldati si portano addosso che - guardi l’assurdo - il valore stesso della vita umana. Lo stesso avviene nel quotidiano: diventiamo significativi solo quando sosteniamo l’economia attraverso il consumo». - Ci può raccontare qualcosa della sceneggiatura, di come intende raccontare la Grande Guerra?
«Nel 1969 ho fatto un film che si intitolava “I recuperanti” e racconta di quegli uomini che finita la guerra andavano a cercare le bombe per sopravvivere. Uno di questi recuperanti si chiamava Toni Matto, era pastore dell’Altipiano e mi ha raccontato molte storie sulla prima guerra mondiale. Questo mio copione è tratto soprattutto dalle storie che mi ha raccontato Toni Matto, che è stato anche guida per i suoi ufficiali perché, in quanto pastore dell’Altopiano, di giorno e di notte, in qualsiasi punto si trovava sapeva dov’era. Il suo fare il pastore lo aveva portato fin da piccolo a esplorare l’altopiano. Mi ha raccontato storie straordinarie e la gran parte di queste storie sono finite dentro questa sceneggiatura. Per il resto, soltanto nel momento in cui sarò lì il primo giorno a battere il primo ciak comincerò a capire qualcosa. Ma la mattina dopo, al secondo ciak, dovrò ricominciare a capire. E via via. Quando avrò finito il film penso che qualcosa avrò capito».
- Lei ha sempre creduto molto nei giovani a partire da Ipotesi Cinema. Un film sulla Grande Guerra come sarà accolto dai giovani un secolo dopo?
«La celebrazione è un atto dovuto. Quello che a me interessa è riuscire a suscitare un’emozione nei giovani d’oggi perché è proprio attraverso l’emozione che si può capire meglio la realtà. C’è un livello emotivo che viene prima ancora del ragionamento razionale che è l’input alle domande che dobbiamo porci. Se uno vede un bel volto e lo affascina, ecco che l’emozione lo costringe a porsi delle domande. Soltanto il filo emotivo può legare i popoli e le generazioni tra loro. Si pensi alla musica e a quanta umanità ha unito».
- Il film si farà dunque ad Asiago?
«Sì proprio qui davanti a casa, per via di quelle tracce sotto il velo pietoso dell’erba». -Domenica presenterà ad Asiago la sua autobiografia. Perché si sceglie di condividere i ricordi di una vita? A chi si rivolge? La nostra società, cosiddetta avanzata, ha perso in molte occasioni il gusto di ritrovarsi, di avere degli spazi da condividere al di là della pratica quotidiana del nostro lavoro, di dialogare insieme. Questo libro è una lettera che scrivo ai miei amici».
-È il racconto di ottant’anni di vita, ma anche di ottant’anni di Italia. Come vede il futuro?
«Il futuro lo vedo come un continuo interrogarci sulle scelte da fare. Il problema di fondo è non rassegnarsi mai. La vita è troppo importante per ciascuno di noi per spenderla male. Diamoci ogni giorno un motivo per esistere e per resistere».
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








