I segreti cosmici di Kepler 186 fratello gemello della Terra
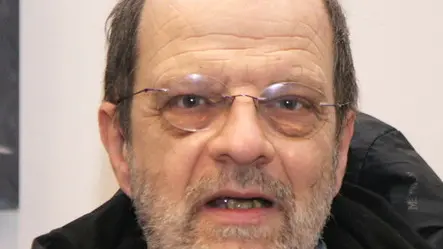
di Aldo Comello
Si chiama Kepler 186 f., assomiglia alla Terra come una goccia d’acqua ed è anche un vicino di pianerottolo. Si trova ad “appena” 500 anni luce dal nostro pianeta, nella costellazione del Cigno (ma se poi provi a moltiplicare i 300 mila chilometri al minuto secondo della luce per arrivare a un’ora, un mese, un anno, 500 anni, vien fuori davvero una cifra astronomica, migliaia di milioni di chilometri, una distanza insuperabile). È roccioso, e ha oceani d’acqua, è dotato di atmosfera, proprio come la Terra, tutti elementi necessari ma non sufficienti alla vita. Anche le dimensioni sono analoghe: è il 10 per cento più grande del nostro mondo.
La scoperta di questo nuovo pianeta extrasolare con talenti di abitabilità così spiccati è stata fatta di recente dalla Nasa. Kepler 186 si trova nella cosiddetta area “Goldilocks” (Riccioli d’oro), denominazione che si ispira alla favola della ragazza che trova nel bosco una casetta abitata da tre orsetti gentili che le offrono una minestra. Lei rifiuta la scodella troppo fredda e quella troppo calda e si mangia quella intepidita dal fiato del plantigrado più buono. «L’area cioè» spiega Leopoldo Benacchio, docente ordinario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica «non deve avere il sedere troppo vicino né troppo lontano da quella “graticola o stufa elettrica” che è la stella. Nel nostro sistema solare la fascia in questione si trova tra Marte e Venere. Ma oltre alla posizione occorre tener conto anche di altri fattori che incidono sulla vivibilità. Su Venere, per esempio, l’effetto serra è così potente che la temperatura al suolo si colloca tra i 300 e i 400 gradi».
Per la legge dei grandi numeri i pianeti con fattori di abitabilità, le cosiddette civiltà tecniche, secondo l’astronomo Drake, dovrebbero essere 600 (ma siamo nel campo delle ipotesi, mica le abbiamo contate). Resta il fatto che la nostra Via Lattea conta 100 miliardi di stelle e per le altre galassie visibili il conto arriva a 10 mila miliardi. «Se in alcuni pianeti extrasolari la vita è teoricamente possibile» dice Benacchio «bisogna intendersi di che vita parliamo».
Secondo il Calendario geologico che mette a confronto la storia della Terra (circa 4,5 miliardi di anni) con un anno solare: l’Homo Sapiens compare qualche minuto prima della mezzanotte del 31 dicembre. Ma protozoi, batteri, scintille di vita, esistono già da qualche milione di anni. Ci sono esserini che si nutrono di gocce di petrolio; il Geodermatophilus Obscurus Everesti è un microrganismo che abita a 8000 metri, sulle pendici dell’Himalaya e chissà cosa mangia (escrementi di yak o di uomo delle nevi?). Fanno parte dell’essere ma non sanno di essere.
Benacchio spiega che c’è anche un altro elemento che ha favorito lo sviluppo della vita sulla Terra: la Luna. La Luna che si trovava a 80 mila chilometri dal nostro pianeta ora si è allontanata alla distanza di 300 mila. Quando era più vicino il satellite influiva sulla rotazione del pianeta e, soprattutto, provocava maree più potenti di uno tsunami: l’acqua dalla laguna cresceva fino alle Alpi o all’altipiano di Asiago per poi riversarsi, mineralizzata, in mare, un processo di fecondazione della vita.
Durante un pranzo alla mensa dei laboratori di Los Alamos, discutendo con un collega sulla presunta apparizione di un Ufo, Enrico Fermi avrebbe esclamato: «Where is everybody?» («Dove sono tutti quanti?». Cioè, se esistono tante civiltà evolute perché non abbiamo nessuna prova della loro esistenza: né segnali radio, né sonde, né navi spaziali? C’è contrasto tra la sensazione di non essere soli nell’Universo e il fatto che non esistono dati osservabili. O non siamo in grado di ricevere i messaggi per carenza tecnologica oppure i nostri potenziali interlocutori non hanno nessuna voglia di parlare con noi. Certo, c’è anche il problema delle distanze. Ci vogliono 2 milioni di anni per raggiungere la galassia più vicina. Magari il messaggio è partito nel Medioevo ma è più lento degli auguri di Natale, lo riceveranno i nostri pro-pro-pronipoti. Il progetto Seti ha attrezzato a Portorico un potente radiotelescopio che finora non ha captato niente a eccezione di un segnale raccolto da Ehman il 15 agosto del 1977. Diceva: “Wow!”.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








