Le divine nel guizzo folle e felice di Boldini
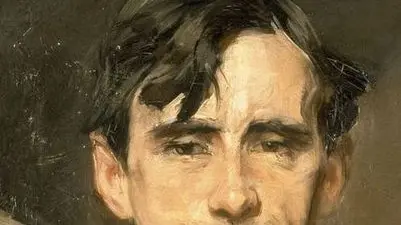
di Virginia Baradel
Che Giovanni Boldini fosse “le peintre magicien” della Belle Époque, è cosa nota e apprezzata in ogni periodo del Novecento, senza cedimenti critici significativi negli anni della reazione più severa alle frivolezze degli anni folli. Tuttavia, vedere riunita la galleria delle sue “divine” spumeggianti, piene di classe, malizia e raffinata voluttà, è un vero lampo di beatitudine terrena. Osservare quelle pennellate affilate che volteggiano rapide e sicure come colpi di fioretto e che talora s’incagliano in un piccolo tripudio di tocchi arruffati, un grumo di virgole guizzanti, quando arrivano, poniamo, all’ornamento che esalta il decolletè, è sempre una delizia. Tanto più se, accanto e intorno, c’è molto altro per comprendere la vicenda artistica del più brillante tra gli italiani di Parigi.
Accade a Forlì, ai Musei di San Domenico arrivati al decimo appuntamento con la grande arte tra Ottocento e Novecento. “Boldini. Lo spettacolo della modernità”, fa ben capire come sia stato il pittore ferrarese a coniare la cifra più calzante della Belle Époque. Aveva ragione il suo conterraneo Filippo de Pisis ad esclamare, visitando la retrospettiva parigina nel 1931, a pochi mesi dalla morte: «C’est un classique!», ovvero l’interprete per eccellenza di quel mondo.
Curata da Francesca Dini e Fernando Mazzocca, diretta da Gianfranco Brunelli, la mostra vanta una scenografia che consente di ambientarsi subito in quella Parigi énchanté, dove tutto si muove con una verve e una rapidità sconosciute sino a pochi anni prima. Grandi pannelli fotografici ricreano la Parigi fin de siècle e un fronte di legno a tre arcate simula la facciata della Gare d’Orsay sulle cui vetrate scorre una multivision di scorci parigini, ritratti di protagonisti (da Proust a D’Annunzio), scene di film, dettagli boldiniani. Un tourbillon d’immagini che ricrea la scena della capitale della modernità, sfondo ideale per il milieu boldiniano di grandi dame, banchieri, scrittori, artisti. Il buonumore che quella gaudente stagione trasmette, introduce ai bocconi più ghiotti della mostra, “divine” a parte. Boldini disegnatore e incisore è un supplemento di conoscenza che rafforza l’idea reggente di un pittore di segno, non di materia. Si capisce bene come struttura e spazio partano da una sicurezza di tratto che assesta già, nero su nero, figure, scene, effetti di luce.
Trasferitosi nel 1871 a Parigi dalla Toscana, dove aveva vissuto in prima linea la stagione macchiaiola ben rappresentata nella mostra di Forlì, Boldini affronta voracemente e in presa diretta la ribalta parigina catturandone l’essenza con disegni veloci e sintetici dove ferma l’istante della folla che ondeggia, dei tram in corsa, del via vai nei bistrot. Il guizzo del carboncino non s’arresta, anzi s’impenna, davanti al tema dei cavalli in movimento, cruciale per tutto il corso della modernità, da Fattori a Boccioni. Tale abbrivio trascorrerà in quei dipinti dove maggiore è l’animazione e dove il segno si fa sempre più impetuoso e vitalistico.
Ci sono dei nudi di modelle che, stese sulla famosa duchesse del suo studio, sembrano sfidare le leggi della gravità, sorrette da scomposti e vibranti fruscii di pennellate. Non era certo un Adone, Boldini, ma conosceva bene le lusinghe della seduzione e non si risparmiava al proposito. La sua statura e le sue fattezze si prestavano molto alla caricatura come si vede nelle illustrazioni di George Gourçat, in arte Sem, che fa brillante mostra di sé nei ritratti che gli fece Boldini. La sala delle illustrazioni satiriche è un tuffo nel risvolto ironico della Belle Epoque, dentro a uno sguardo feroce che mette alla berlina frivolezza e ostentazione, vezzi teatrali della mondanità.
Anche il parallelo con Paul Helleu, grafico di gran spicco, amico di Sargent, Whistler, protetto da de Montesquiou, è una chiave importante per capire meglio la temperatura estetica di quel tempo in cui Boldini esercitava la sua signoria come pittore e come personaggio. Chi contava sul serio sulla scena del bel mondo, si meritava la gloria di un vero ritratto, fremente come un’istantanea, definitivo come un diamante.
I soggetti maschili, da Giuseppe Verdi al marchese di Rudinì, trovano un perfetto contrappunto nelle sculture di Paolo Troubetzkoy che restituiscono nel bronzo, la fugace e sommaria verità della posa immediata. Lo scultore di origine russa punteggia anche la galleria delle magnifiche dame che svettano indomite su piume e fiocchi, pegno d’irresistibile levità. Sguardi, pose e cadenze, trasformate in nettare degli dei da un pennello invaghito di tanta grazia, rendono queste dame le legittime sovrane dell’ âge d’or della modernità. E tuttavia, pur se il suo tratto sicuro, sfila, frange e saetta, Boldini ha ben presente i modelli della grande storia.
Una felice sorpresa aspetta il visitatore nell’ultima sala. “Il cardinale Guido Bentivoglio” di Van Dyck troneggia tra la maliarda Miss Bell e l’irresistibile Dama di Biarritz. Un colpo di teatro della storia dell’arte nient’affatto arbitrario: affinità emergono dal fermo immagine su gesti scattanti, crepitî di sete, sfondi dove domina un’animata oscurità. Boldini ammirava i grandi ritrattisti, prendeva nota, assimilava. Così non sfigurano i più composti Monsieur Poidatz e René Cole a confronto con i fratelli pittori de Wael dipinti sempre da Van Dyck, mentre due principesse spagnole (Eulalia di Spagna e Tadea Arias de Enriquez) misurano la distanza e i riverberi d’eco tra Boldini e Francisco Goya.
Conclude la mostra una carrellata di italiani a Parigi, De Nittis, Zandomeneghi, De Tivoli, Corcos con il contraccolpo, all’uscita, di Madame Modot di Amedeo Modigliani: come a dire che non solo la mostra è finita, ma un’intera epoca.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








