Il monaco Rufino in fuga dal limes
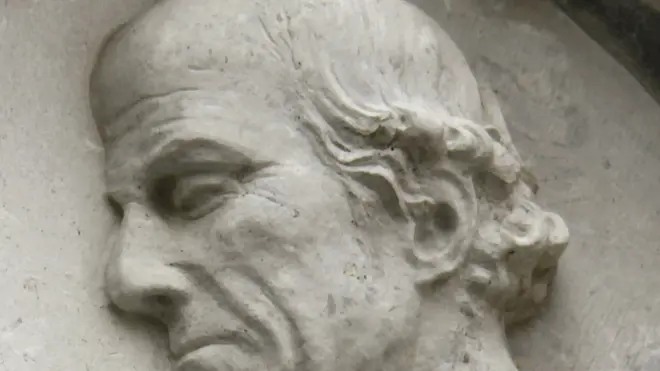
di Georgia Schiavon
CONCORDIA SAGITTARIA
«O venerando padre Cromazio, nel tempo in cui rotte le difese d’Italia da Alarico duce dei Goti, il morbo pestifero vi penetrò e devastò per ogni dove i campi, gli armenti, gli uomini, tu hai ritenuto che convenisse tenere occupate in migliori applicazioni le menti affrante». Sono i primi anni del 400. Aquileia, capitale della decima regio imperiale, la Venetia et Histria, ha appena subito l’assedio visigoto. Cromazio, al seggio vescovile aquileiese, commissiona al monaco Rufino di Concordia la traduzione in latino e l’aggiornamento della “Storia ecclesiastica” di Eusebio di Cesarea: nelle intenzioni del vescovo, la solida continuità della chiesa cristiana dovrebbe offrire un baluardo interiore nei confronti delle angosce generate da una situazione geopolitica resa instabile dalla minaccia barbara che incombe sul limes, il confine orientale dell'impero romano d'Occidente. La mostra “L'Oriente in Occidente”, appena aperta, si disloca tra il Museo concordiese di Portogruaro e le aree archeologiche di Concordia Sagittaria fino al 15 dicembre, inquadra la figura di Rufino nella macrostoria del suo tempo e ne analizzerà l’opera di traduttore ed esegeta in un convegno conclusivo. Rufino Turranio nacque nel 345 a Iulia Concordia, colonia romana con una consolidata presenza cristiana. Lo stesso Cromazio, nel 389, vi consacrò la basilica apostolorum, sottolineando nel suo sermone il legame spirituale della comunità concordiese con la chiesa di Aquileia. Una contiguità sussistente anche sul piano strategico: Iulia Concordia fungeva da retroguardia di Aquileia nella critica zona del limes, come emerge dalle testimonianze della presenza stanziale di una ventina di reparti della milizia romana e dell'esistenza di una fabbrica di frecce, le sagittae (dalle quali l’attuale epiteto della città, Sagittaria), attiva almeno dall’inizio del quarto secolo. Dopo gli anni di formazione a Roma e ad Aquileia, dove ricevette il battesimo, intorno al 370 Rufino partì per l’Oriente, alla ricerca delle radici della sua fede. Saggiata la vita anacoretica dei padri del deserto in Egitto, avvicinato il pensiero di Origene ad Alessandria, alla scuola di Didimo il Cieco, si stabilì a Gerusalemme, dove fondò un monastero. Al suo rientro a Roma, nel 397, cominciò il suo impegno nella trasmissione del patrimonio culturale acquisito in Oriente attraverso la traduzione dal greco – in una fase di declino della conoscenza di questo idioma nel mondo latino – di molte opere dei padri della chiesa, alcune delle quali, diversamente, sarebbero oggi perdute. È il caso del trattato “Sui princìpi” di Origene, autore allora controverso in quanto considerato da una parte dell’intellighenzia cristiana la sorgente dell'eresia ariana, già condannata per due volte in sede conciliare, a Nicea nel 325 e proprio ad Aquileia nel 381. La scelta riaccese la disputa origenista, che lo vide opporsi a san Girolamo, al punto da causare la fine della loro amicizia.
La successiva, più penetrante, incursione visigota lo costringerà nel 410 a lasciare Roma, dov'era ritornato dopo il periodo trascorso ad Aquileia, per rifugiarsi in Sicilia, dove morirà nel 411. Nei primi anni del 450 Aquileia è devastata dal prolungato assedio degli Unni di Attila, che, attraverso la via Annia, raggiungono anche Iulia Concordia. La capitale della decima regio ha perso la sua supremazia militare e religiosa. Il limes orientale si è sgretolato. L’impero d'Occidente è al tramonto.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








