“L’azione perfetta” Scabia racconta l’Italia con le traveggole
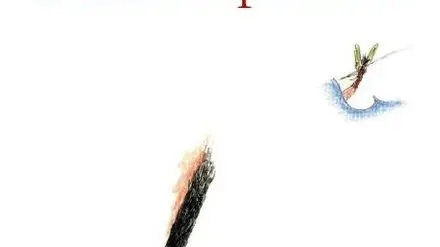
di Nicolò Menniti-Ippolito
Giuliano Scabia ha impiegato quasi quarant’anni a scrivere la sua storia del Novecento. Che è una storia ovviamente a modo suo, di uno scrittore, cioè, che racconta la realtà ricreandola, trasformandola in teatro e in poesia, ammesso che per lui siano cose diverse. “L’azione perfetta” (Einaudi, p. 256, 22 euro), che è da oggi in libreria, è il terzo capitolo di un ciclo narrativo, che lo scrittore e teatrante padovano, oggi ottantenne, ha cominciato a scrivere nel 1980, pubblicando poi il primo capitolo, “In capo al mondo” nel 1990 e il secondo, “L’acqua di Cecilia”, nel 2000. Insieme i tre capitoli (ma forse ce ne sarà un quarto, perché manca un pezzo di storia, ancora) compongono il “ciclo dell’eterno andare”, che si affianca a quel ciclo di “Nane Oca”, che è l’altra sorgente narrativa di Giuliano Scabia.
Queste trilogie sorelle non solo si rispecchiano tra loro, ma diventano anche la cornice in cui inserire, per capirlo fino in fondo, anche i versi di Scabia e il suo teatro. Scabia non è solo uno scrittore, è un creatore di mondi fantastici, che hanno però radici profonde nella realtà, anzi sono strumento per raggiungere una visione più autentica della realtà. C’è una parola che Scabia ama molto e ritorna spesso in “L’azione perfetta” ed è “traveggola”. La traveggola è per Scabia il vedere ciò che non esiste, per esempio gli angeli parlare, ma è anche l’intravedere qualcosa che i più non vedono. Ecco: il ciclo dell’eterno andare racconta la storia d’Italia con le traveggole.
I protagonisti dei primi due romanzi, riuniti insieme in “Lorenzo e Cecilia”, erano il violoncellista Lorenzo con la prima moglie Irene e il suo secondo amore: Cecilia. La loro storia copriva la prima metà del Novecento, mentre “L’azione perfetta” racconta la seconda metà del secolo con un occhio particolare a Padova e a Venezia, i luoghi dove Scabia si è formato, ma anche i luoghi della sua narrativa: come Dublino per Joyce, direbbe lui un po’ridendo. La protagonista è questa volta Sofia, la figlia di Lorenzo e Cecilia, che attraversa col suo lucido buon senso e le sue traveggole le tensioni degli anni Sessanta, il terrorismo degli anni Settanta, l’infatuazione collettiva per la rivoluzione, e nello stesso tempo prova a darsi ragione della morte precoce del padre, della scoperta del corpo e del sesso, del peso del passato, dei meandri della mente umana, della pazzia e della sanità, del teatro come rappresentazione di ciò che c’è e insieme non c’è. C’è cronaca: la distruzione di Padova come città d’acqua con l’interramento dei canali, la prima contestata di Luigi Nono alla Fenice, i pestaggi degli anni di piombo, gli omicidi delle Brigate rosse. C’è anche la storia (l’Ungheria, la Primavera di Praga, Piazza Fontana), ma Scabia ha voluto separarla dal corpo principale del testo, per non incorrere nel romanzo storico.
Attraverso Sofia racconta, a partire dal padre violoncellista, un po’ anche la sua vita. E lo fa con gli echi ariosteschi, con lo sfondo foscoliano, con lo straniamento brechtiano riadattato però a corde diverse, quali sono le sue. C’è veramente gran parte della cultura e della politica del secondo Novecento in questo libro, ma Scabia non dà giudizi, e questo gli permette di raccontare con grande libertà ed in qualche modo con leggerezza quello che la cultura italiana spesso non ama raccontare, per esempio la violenza politica. Non è mai, per Scabia, bianco o nero, bene o male. È sempre si e no, che è non significa non prendere posizione, ma portare attenzione alla complessità delle vite e della psiche, di un mondo popolato di più cose di quelle che vediamo, perché anche le parole hanno vita, e così i morti, i sogni; e solo un’azione perfetta, vita o teatro che sia, può tenere tutto insieme.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








