Ricerca sul cancro, i nuovi progetti dell’Università di Padova sostenuti da Fondazione Airc
Approvata l’erogazione di fondi per 37 progetti e borse di studio legate a diverse aree scientifiche, con un sostegno complessivo di oltre quattro milioni di euro
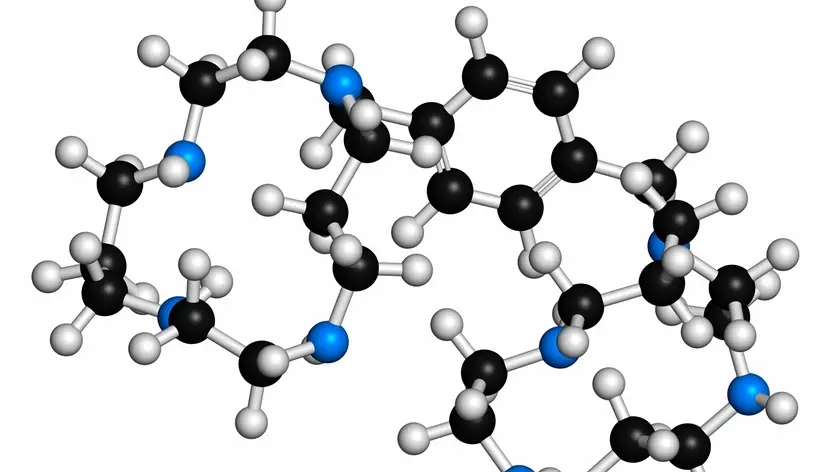
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha approvato l’erogazione di fondi per 37 progetti e borse di studio presso l’Università di Padova, afferenti a diverse aree scientifiche, con un sostegno complessivo per il 2023 di 4.063.757,47 di Euro.
Si tratta di fondi destinati alla ricerca contro il cancro, ottenuti dai ricercatori tramite il processo di valutazione di AIRC, basato sulla selezione trasparente e indipendente del merito scientifico di ogni progetto.
AIRC sostiene, nell’ambito dei programmi “5 per mille”, le ricerche di Matteo Fassan, Valentina Guarnieri, Stefano Piccolo e Rosario Rizzuto.
La maggior parte dei fondi AIRC è destinata a progetti di ricerca della durata di cinque anni. Di questi, i progetti di tipo “Investigator Grant” sono guidati da ricercatori affermati e i fondi assegnati coprono il costo della ricerca più quello del personale in formazione che vi lavora. All’Università di Padova, nel 2023, iniziano sei nuovi progetti selezionati da AIRC e condotti da Marco Agostini, Silvia Bresolin, Michelangelo Cordenonsi, Maria Vittoria Dieci, Massimo Santoro e Ildikò Szabò.
Questi si aggiungono ai progetti già in corso e rinnovati, condotti da Paolo Bernardi, Vincenzo Ciminale, Sirio Dupont, Monika Fuxreiter, Arianna Loregian, Fabrizio Mancin, Maria Pennuto, Stefano Piccolo, Erich Piovan, Sara Richter, Chiara Romualdi, Antonio Rosato, Marco Sandri, Claudia Sissi, Gyorgy Szabadkai, Silvio Tosatto, Livio Trentin e Gianpietro Viola.
Le “Borse per l’Italia” sono assegnate a giovani ricercatori, a volte anche neolaureati, prima o dopo avere conseguito un dottorato. Si tratta di borse di formazione dedicate all’apprendimento delle basi della ricerca, che offrono la possibilità di acquisire esperienza in Italia presso un laboratorio d’eccellenza. I beneficiari presso l’Università di Padova sono Maddalena Benetton e Mouawad Nyala.
Il “My First AIRC Grant” (MFAG) è invece assegnato a ricercatori che abbiano già maturato un’esperienza di ricerca oncologica in Italia o all’estero. I fondi offrono la possibilità di sperimentare la conduzione del proprio progetto in una struttura italiana di eccellenza e di diventare progressivamente autonomi e indipendenti. A Padova i ricercatori già sostenuti con un MFAG, oltre alla new entry per il 2023 Patrizia Romani, sono: Vincenzo Amendola, Enrica Calura, Gaia Codolo, Luigi Leanza e Marco Montagner.
I grant Start-Up sono assegnati a ricercatori eccellenti che abbiano già dimostrato una significativa esperienza scientifica in un laboratorio all’estero e permettono di gestire il lavoro di ricerca in assoluta autonomia avviando un laboratorio in Italia. All’Università di Padova Francesco Boccalatte può lavorare grazie a un grant Start-Up.
I nuovi progetti avviati nel 2023
“Investigator Grant”
Marco Agostini, Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche
Titolo del progetto: Modello di un chip integrato multicellulare: un ruolo nuovo ed inesplorato per il cancro del retto
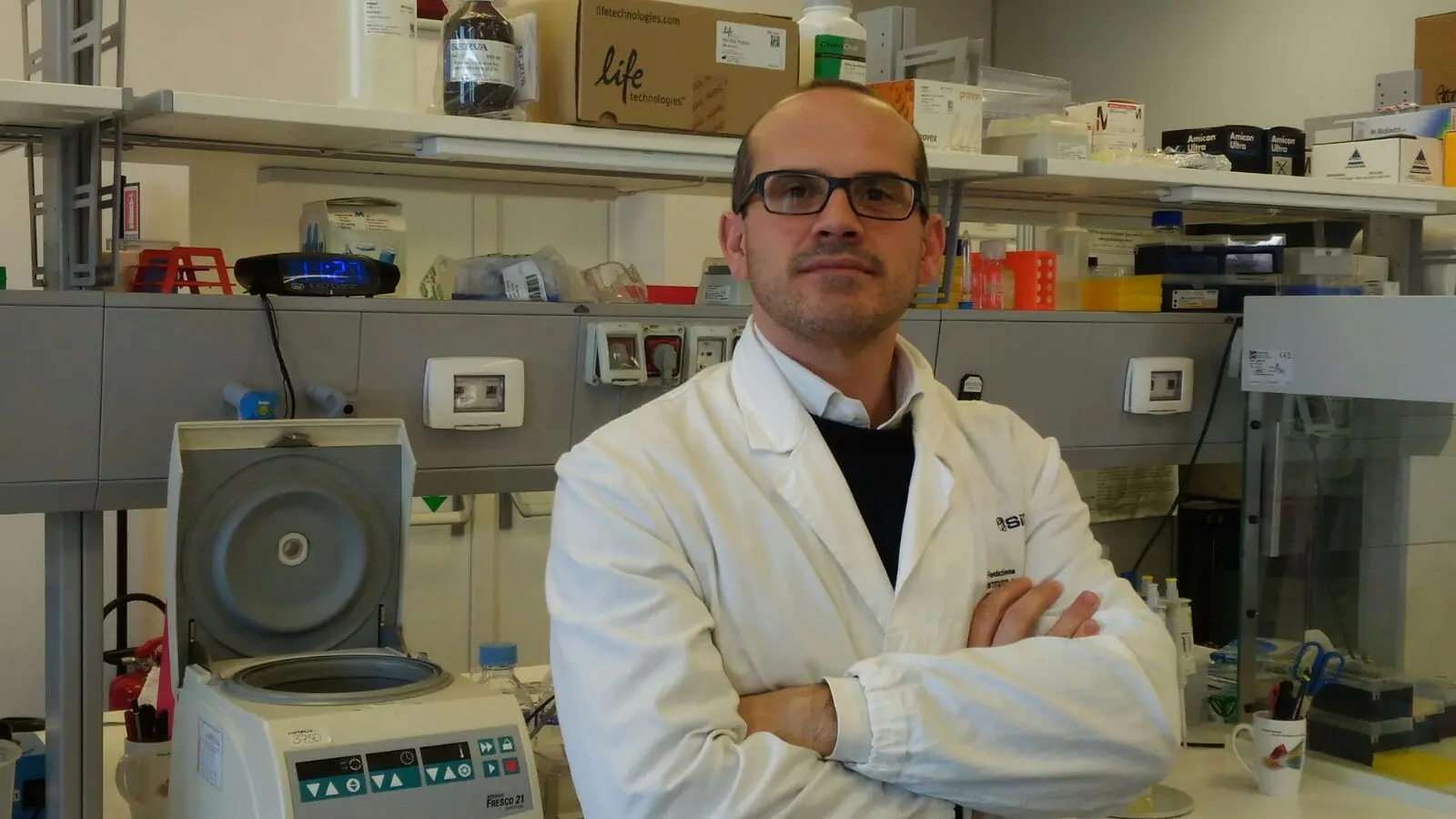
I ricercatori hanno sviluppato un modello in tre dimensioni, detto PhiC e derivato da campioni di pazienti, con cui mimare il microambiente del tumore. Con PhiC è possibile riprodurre in laboratorio alcuni aspetti biologici dell’ambiente tumorale e identificare nuovi meccanismi molecolari alla base del processo di sviluppo del cancro.
Si possono per esempio identificare nuovi geni coinvolti nel processo tumorale che potrebbero essere usati come nuovi bersagli terapeutici. Inoltre si può studiare il ruolo, nel tumore, della matrice extra cellulare, in termini di componenti biochimiche e biofisiche, nel controllo del potenziale cancerogeno e immunogenico. Infine potrebbe essere possibile sviluppare un tipo di coltura cellulare in tre dimensioni per ottimizzare la valutazione dell'efficacia dei farmaci in tempi brevi.
La combinazione di tecniche di microfluidica, di colture di organoidi tumorali derivate da pazienti e di ECM-idrogel prende il nome di "tumor-on-a-chip". Potrebbe consentire la progettazione di un microambiente dinamico adatto alla valutazione dell’efficacia e degli effetti dei trattamenti, più vicino alla risposta osservata nei pazienti. Questo approccio potrebbe anche permettere ai medici di procedere in modo meno invasivo al recupero del materiale biologico da pazienti tramite biopsie, necessarie a effettuare la diagnosi. Inoltre potrebbe aumentare la riproducibilità e la ripetibilità delle analisi diagnostiche stesse.
La possibilità di studiare il microambiente tumorale in un chip per studi di efficacia dei farmaci potrebbe aumentare il tasso di risposta alla radiochemioterapia nei tumori solidi, e di conseguenza la sopravvivenza dei pazienti.
La piattaforma microfluidica completamente integrata, chiamata PhiC, potrebbe infine consentire di eseguire lo screening funzionale di combinazioni di farmaci a partire da un numero limitato di cellule, consentendo così la previsione di trattamenti mirati a tumori solidi primari umani.
***
Silvia Bresolin, Dipartimento di salute della donna e del bambino
Titolo del progetto: Una strategia multimodale integrata a singola cellula per eradicare la leucemia mielomonocitica giovanile.
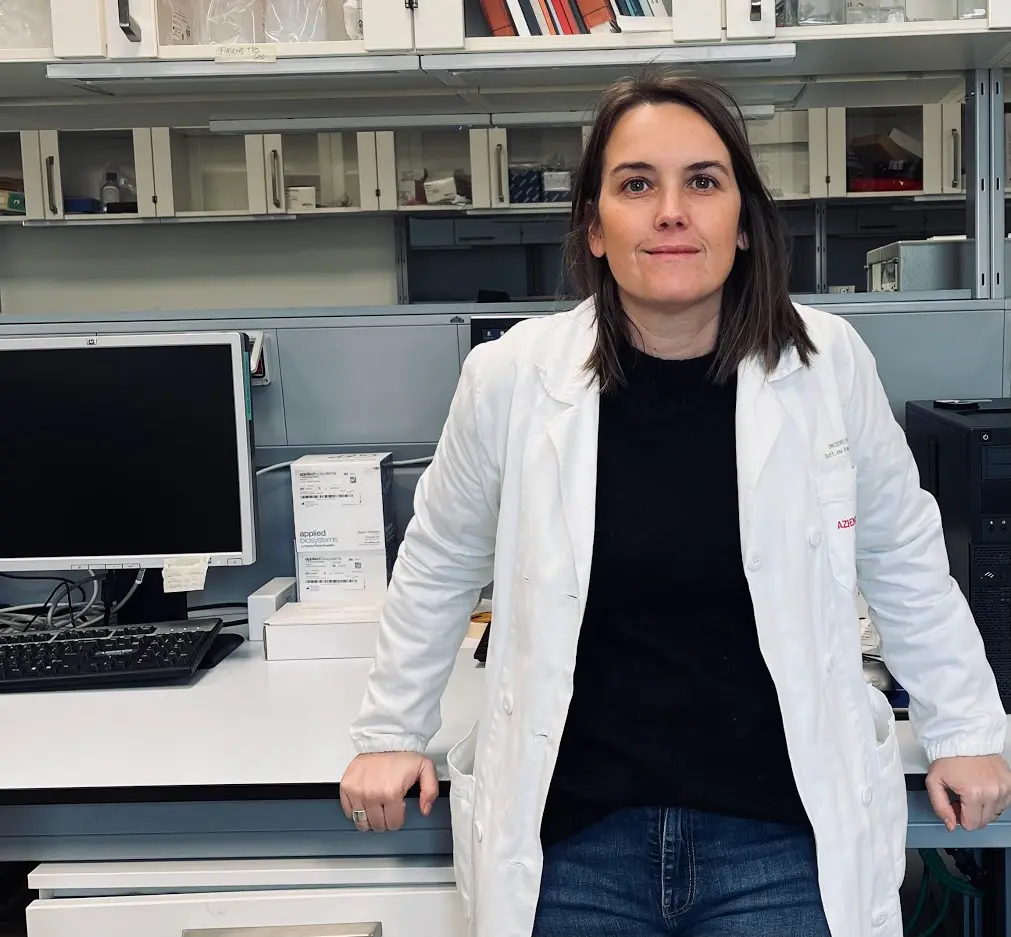
Obiettivo del progetto di ricerca è la caratterizzazione a singola cellula dei complessi meccanismi molecolari che promuovono la progressione della leucemia mielomonocitica giovanile e la resistenza alle terapie. Questa rara forma di tumore della sangue è un tipo di leucemia ancora difficile da curare, che colpisce i bambini in giovane età. Più in dettaglio, si studieranno le interazioni regolative tra trascrittoma ed epigenoma nelle cellule responsabili delle ricadute e inoltre il ruolo del metabolismo nel sostegno di questi meccanismi molecolari presenti nelle cellule dei pazienti ad alto rischio.
Nello studio, inoltre, si cercherà di identificare i processi biologici indispensabili alla sopravvivenza delle cellule tumorali, con l’obiettivo di individuare così possibili nuovi bersagli terapeutici per possibili terapie più efficaci, specialmente per i pazienti che a oggi non possono beneficiare del trapianto di cellule staminali.
***
Michelangelo Cordenonsi, Dipartimento di Medicina molecolare
Titolo del progetto: Come l’invecchiamento dell'individuo e la senescenza dei tessuti influenzano l'insorgenza dei tumori
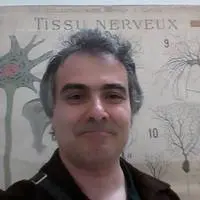
Obiettivo del progetto è mappare, nel corso dell’invecchiamento, i cambiamenti delle cellule che compongono i tessuti e le alterazioni delle loro interazioni. In particolare si studieranno le modifiche che promuovono la formazione di tumori quale conseguenza del fenomeno dell’invecchiamento. Per fare questo, i ricercatori cercheranno di riprodurre in cellule in coltura e in animali di laboratorio questi fenomeni, nei quali potranno accelerare sperimentalmente l’invecchiamento mediante induzione della senescenza cellulare.
Lo scopo della ricerca è duplice: identificare dei marcatori con cui identificare situazioni favorevoli all'insorgenza dei tumori prima che questi si sviluppino, allo scopo di agire per tempo con terapie preventive adeguate; identificare i processi necessari alla tumorigenesi da invecchiamento, allo scopo di scoprire nuove vulnerabilità dei tumori, possibilmente individuando opzioni per interventi preventivi contro l’insorgenza di tumori in tarda età.
***
Maria Vittoria Dieci, Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche
Titolo del progetto: Personalizzazione del trattamento con immunoterapia per pazienti con diagnosi di carcinoma mammario “triplo negativo” attraverso lo studio del profilo immuno-metabolico del tumore e dell’ospite

Il tumore cosiddetto “triplo negativo” costituisce circa il 10-15% di tutti i tumori della mammella ed è il sottotipo più difficile da curare per il quale, fino a pochissimo tempo fa, la chemioterapia rappresentava l’unica opzione di cura farmacologica.
Oggi alcuni farmaci immunoterapici sono potenzialmente in grado cioè di stimolare il sistema immunitario delle pazienti a eliminare le cellule tumorali. L’aggiunta di questi trattamenti alla chemioterapia può permettere di ottenere importanti risultati e di aumentare l’efficacia delle cure. Tuttavia, non è ancora chiaro quali pazienti possono trarre beneficio da questa strategia. Per chi non ne beneficia, l’aggiunta dell’immunoterapia rischia di produrre solo un potenziale incremento di tossicità.
Nel progetto si punta pertanto ad approfondire gli aspetti immunologici e metabolici caratteristici del tumore e delle pazienti, e a studiarne le interconnessioni. Lo scopo ultimo è definire un profilo immunometabolico in grado di aumentare l’efficacia e la precisione del trattamento immunoterapico per pazienti con tumore mammario triplo negativo.
***
Massimo Santoro, Dipartimento di Biologia
Titolo del progetto: Verso nuovi approcci terapeutici per il melanoma: il ruolo del mevalonato nel melanoma metastatico.

Il melanoma metastatico è un tumore maligno ancora difficile da curare, nonostante i progressi nei trattamenti mirati e nell’immunoterapia.
Nel processo di diffusione metastatica le cellule di melanoma vanno incontro a cambiamenti metabolici che contribuiscono alla loro sopravvivenza.
In questo studio i ricercatori si prefiggono di identificare tali cambiamenti e di utilizzarli per progettare nuove strategie terapeutiche.
***
Ildikò Szabò, Dipartimento di Biologia
Titolo del progetto: Dal trattamento combinato che arresta la progressione dei tumori a prognosi sfavorevole verso una possibile applicazione clinica

Nonostante i recenti progressi diagnostici e terapeutici, l’adenocarcinoma duttale del pancreas (PDAC) e il carcinoma mammario mantengono un'elevata incidenza e la prognosi di sopravvivenza è sfavorevole quando queste malattie sono resistenti ai farmaci chemioterapici.
Recentemente il gruppo di ricerca guidato dalla prof.ssa Szabò ha sviluppato inibitori specifici contro due canali ionici mitocondriali.
Tali inibitori hanno selettivamente eliminato le cellule di PDAC in esperimenti con animali di laboratorio, impedendo la diffusione metastatica del tumore. I risultati preliminari indicano che la combinazione di questi farmaci con gli agenti chemioterapici attualmente utilizzati può riuscire a eliminare del tutto il tumore in topi di laboratorio con PDAC, senza provocare una diminuzione immunitaria né altri segni di tossicità.
L’ipotesi dei ricercatori è che l’inibizione farmacologica dei canali mitocondriali e il trattamento combinato possano influenzare la funzione immunitaria nel microambiente tumorale, oltre a uccidere le cellule tumorali. Questa duplice azione può portare all’eradicazione del PDAC e, auspicabilmente, anche del carcinoma mammario resistente alla chemioterapia.
***
Le “Borse per l’Italia”
Maddalena Benetton, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino
Titolo del progetto: Identificazione delle vulnerabilità delle cellule staminali leucemiche nella leucemia mieloide acuta pediatrica
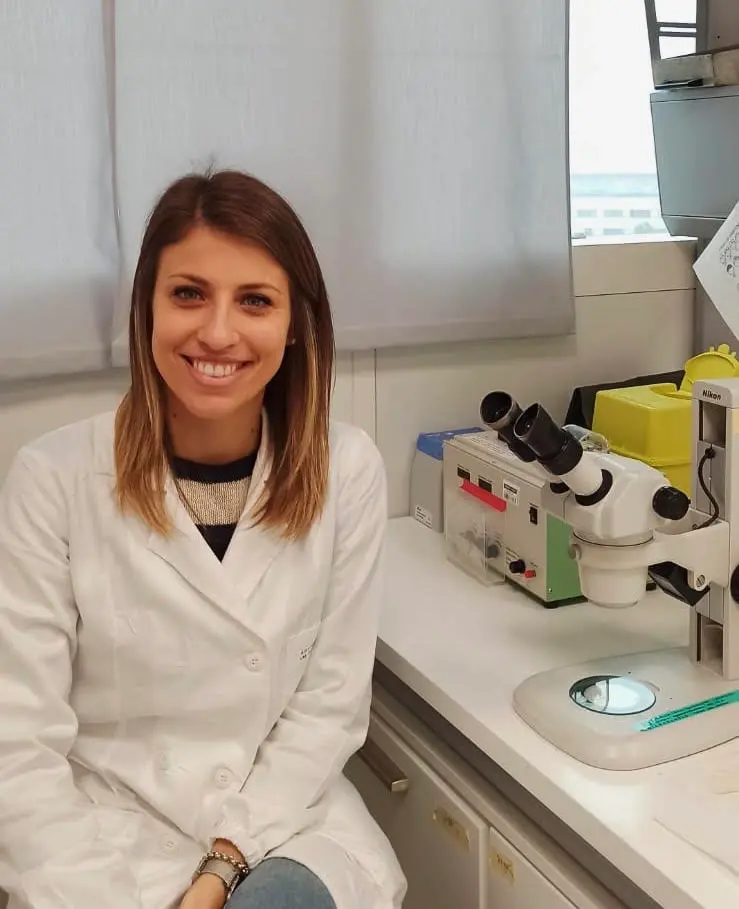
La leucemia mieloide acuta (LAM) è una malattia ematologica caratterizzata dall’accumulo di cellule immature, chiamate blasti, nel midollo osseo. Nel contesto pediatrico, grazie al trattamento con la chemioterapia che colpisce le cellule tumorali altamente proliferanti, la sopravvivenza si aggira oggi intorno all’80%. Tuttavia circa un terzo dei bambini va incontro a ricaduta, pertanto terapie più efficaci sono auspicabili.
Le cellule staminali leucemiche (in inglese leukemic stem cells o LSC) sono ritenute responsabili della recidiva dal momento che, non proliferando attivamente, rispondono meno alla chemioterapia. Identificare le LSC nel clone leucemico e capire i meccanismi che rendono tali cellule resistenti alla chemioterapia è pertanto indispensabile.
Obiettivo del progetto è caratterizzare il metabolismo cellulare delle LSC, ossia quell’insieme di reazioni che forniscono alle cellule l’energia necessaria a svolgere le proprie attività, e la loro aberrante capacità di aderire alla nicchia midollare e di resistere all’azione dei farmaci.
A tale scopo i ricercatori cercheranno di riprodurre in laboratorio una nicchia midollare in tre dimensioni, in cui ricapitolare il più fedelmente possibile l’ambiente fisiologico in cui tali cellule risiedono. In questo contesto si cercherà anche di testare e selezionare farmaci che, da soli o in combinazione con la chemioterapia convenzionale, possano colpire efficacemente le LSC ed eliminare in modo definitivo, insieme a queste cellule, il rischio di recidiva.
***
Nayla Mouawad, Dipartimento di Medicina
Titolo del progetto: Studio della chinasi di adesione focale (FAK) quale nuovo mediatore del cross-talk BCR-ROR1 nella progressione della leucemia linfatica cronica (LLC)

Obiettivo del progetto di ricerca è lo studio della proteina FAK quale mediatore dell’interazione tra due vie di segnalazione, elle quali sono coinvolti rispettivamente il recettore per l’antigene BCR e la proteina ROR1. Tali vie di segnalazione rappresentano interessanti bersagli terapeutici nella leucemia linfatica cronica.
L’identificazione di FAK quale mediatore dell’interazione BCR-ROR1 potrebbe chiarire come le cellule leucemiche di pazienti trattati con farmaci a bersaglio molecolare (ad esempio quelli mirati a BCR) possano passare a una modalità di sopravvivenza dipendente da ROR1 e divenire così resistenti ai farmaci, portando alla progressione della malattia. I risultati ottenuti in quest’ambito di ricerca potrebbero avere una rilevanza clinica e terapeutica.
L’identificazione di nuovi bersagli terapeutici (ad esempio FAK) e di nuovi trattamenti è, infatti, un aspetto importante della ricerca non solo per la gestione ottimale dei pazienti con prognosi poco favorevole, ma anche per il superamento della resistenza ai trattamenti indotta dai nuovi agenti farmacologici.
***
“My First AIRC Grant
Patrizia Romani, Dipartimento di Medicina molecolare
Titolo del progetto: Ruolo della ferroptosi nella disseminazione dipendente da Rac1 delle cellule di melanoma

Obiettivo del progetto è studiare come la ferroptosi sia coinvolta della disseminazione dipendente da Rac1 delle cellule di melanoma aggressivo. La ferroptosi è un particolare tipo di morte cellulare programmata, distinta dagli altri tipi, caratterizzata dall’accumulo di lipidi perossidati e dipendente dal ferro. Il razionale dello studio è basato su risultati, pubblicati in letteratura, che hanno dimostrato come le cellule di melanoma aggressivo resistenti alle terapie siano sensibili alla morte per ferroptosi. Scopo ultimo del progetto è studiare il meccanismo molecolare alla base di questa sensibilità al fine di sviluppare nuove e più efficaci terapie.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








