Ruspante e proletaria, la Padova anni Cinquanta era una “osteria diffusa
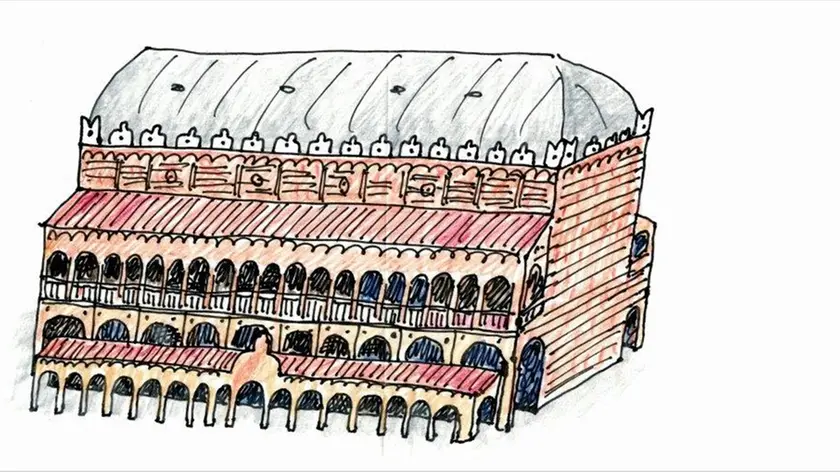
PADOVA. Macché la Milano anni Ottanta delle tre “s”: snob, sciupona, sopra le righe. Già una trentina di anni prima, c’era una Padova da bere ruspante e proletaria, i cui punti cardinali consistevano in quella che oggi i creativi del marketing turistico definirebbero l’”osteria diffusa”: un vero e proprio circuito virtuoso di locali dove il rito laico dell’”ombra” era consumo di relazioni sociali prima ancora che di supporto alcolico; magari accompagnato dalla degustazione di un saporito quanto rude “spunciòn”, spartano precursore dell’odierno stuzzichino, lessicalmente degradato da una turpe moda anglofila all’epiteto di “finger food”.
Era una città in ginocchio, dopo due guerre mondiali in trent’anni che l’avevano vista comunque in prima linea, ma con tanta voglia di ripartire. Il motore della rinascita era il bar Missaglia, espressione di una vera e propria dinasty della mescita: nove figli di una madre rimasta precocemente vedova, con le quattro primogenite che fin dal primo dopoguerra, nel 1919, si erano fatte le ossa gestendo una latteria in via Marsilio da Padova.
Poi nel 1922 erano subentrati quattro maschi, Bepi, Orione, Italo e Ferruccio, aprendo un locale nella vicina via Gorizia, per passare infine nel 1940 nell’odierna sede di via Santa Lucia. Era conosciuto come “la tavernetta dei poeti”, per una serie di quadri del mitico pittore Toni Menegazzo detto Amen, che lo frequentava assieme a una serie di intellettuali padovani di primissimo piano, da Concetto Marchesi a Manara Valgimigli, da Tono Zancanaro a Luigi Strazzabosco.
C’erano pure gli sportivi: qui venivano rugbisti, schermidori, ciclisti, calciatori; in testa quelli del Calcio Padova, che per una breve stagione vennero allenati da un inglese, Frank Soo, il quale pretendeva che non toccassero alcol prima delle partite.
Narra la vulgata popolare che i mascalzoni, al sabato pomeriggio, entrassero da Missaglia chiedendo a gran voce, “il thè delle 5”; subito arrivavano ai tavoli sontuose teiere piene di vin bianco dei Colli. E qui, nel 1946, aprì la prima ricevitoria Sisal, diventata poi Totocalcio.
Ma c’erano anche altre osterie famose, nel centro cittadino: come Nane della Giulia, in via Santa Sofia, dove un cliente fedelissimo usava entrare verso sera chiedendo con voce stentorea, “ombre come se piovesse”. Raccontano che un gruppo di buontemponi vi portò un pittore inglese di passaggio per Padova: il quale, informatosi del significato del nome del locale, impugnò penna a china e album degli schizzi, sfornando su due piedi un’insegna con la ragione sociale tradotta in britannico, “Julie’s John”.
Non solo ombre, però. Il centro storico era una sorta di villaggio dove ci si conosceva tutti, e dove si otteneva un attestato di cittadino di serie A quando ci si guadagnava il soprannome, e con quello si veniva chiamati. Il cognome? Troppo formale.
Il nome di battesimo? Familiare sì, ma pur sempre nella norma. Per acquisire autorevolezza ci voleva un soprannome, che spesso e volentieri echeggiava un trascorso di casato lungo generazioni, o una particolare attitudine.
Memorabile un bidello dell’Istituto di medicina legale, soprannominato “Barnard”, dal nome del chirurgo del primo trapianto di cuore. Andò male solo a un tizio che si guadagnò il marchio di “caribù”, per via delle morose che secondo la voce pubblica gli procuravano corna in quantità industriali; ma già la fantasiosa scelta zoologica dimostrava un’invidiabile raffinatezza.
Che si manifestava anche sotto altre forme, in chiave collettiva: nelle calde sere d’estate, c’erano gruppi di facinorosi che muniti di pallone si vantavano di andare a giocare all’estero, perché improvvisavano accese partite sul sagrato del Santo, zona extraterritoriale in quanto proprietà del Vaticano. I match si concludevano non di rado anticipatamente, quando qualche abitante del posto apriva i balconi imprecando; allora dal campo improvvisato si levava il grido “ocio tosi che i ‘ne butta el bocàl del pisso”, e gli atleti si dileguavano.
Colonne portanti di quella “Padova da bere” erano le cosiddette “macchiette”, veri e propri facebook umani della strada: delle quali andremo a fare la conoscenza in una breve serie di articoli. Qualche epigono dei cosiddetti sindaci-sceriffo che oggi vanno di moda, le multerebbe per offesa al pubblico decoro. Allora, invece, i padovani li adottavano e ci erano pure affezionati. Perché quella era una comunità, non una somma di individui.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








