Valeria, la scrittrice di best seller veneziana per caso
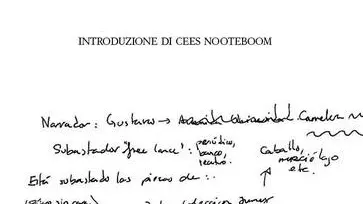
di Nicolò Menniti-Ippolito
Non c’è solo la napoletana Elena Ferrante a figurare con la sua “Storia della bambina perduta” nella lista dei migliori libri del 2015 secondo il New York Times. Un po’ più indietro c’è anche una veneziana, Valeria Luiselli, con “La storia dei miei denti”. Ai veneziani il nome della scrittrice forse non dice tanto e neanche il titolo del libro, eppure Valeria Luiselli è effettivamente residente a Venezia e il suo libro ha avuto molto successo, finora in spagnolo, inglese e tedesco.
La storia è bizzarra, in effetti. Valeria Luiselli è italiana di origine e anche di nazionalità, come si capisce dal nome, ma è sostanzialmente messicana. Lei direbbe che neppure questo è del tutto vero, perché è vissuta da tante parti, al seguito di un padre ambasciatore, e la sua lingua è l’inglese quanto lo spagnolo, ma parla bene anche l’italiano. E Venezia che c’entra allora? C’entra molto, perché la residenza veneziana è per Valeria Luiselli un segno del destino, e anche una condizione esistenziale.
Non ancora trentenne, è considerata uno dei nomi di punta della letteratura mondiale, tanto da attirarsi odi ed invidie. I suoi primi due libri, pubblicati in Italia da “La nuova frontiera”, casa editrice specializzata in letteratura sudamericana, sono stati tradotti in molti paesi e il suo terzo “La storia dei denti”, che in Italia uscirà nel 2016, l’ha vista incoronare da Granta o El pais come la maggiore scrittrice in lingua castigliana della sua generazione. Romanzi come “Carte false” e “Volti tra la folla”, quest’ultimo ripubblicato da “La nuova Frontiera” poche settimane fa, smontano la tradizione narrativa intrecciando storie, autobiografia, saggistica letteraria con una libertà creativa che compare nuovamente anche in “Storia dei miei denti”.
E in questa libertà trova spazio Venezia, che in “Carte false” è cornice autobiografica di una serie di storie che assomigliano a piccoli saggi. In origine Venezia è, per Valeria Luiselli, Iosif Brodskij, o meglio ancora la sua tomba al cimitero di San Michele. E la sepoltura veneziana di Brodskij, accanto a Pound, le pare una di quelle coincidenza che segnano vita e morte. Brodskij si è trovato veneziano in morte, anche se forse avrebbe voluto tornare a Pietroburgo, mentre lei si trova veneziana da viva. E questo lo racconta nell’ultimo capitolo di “Carte false”.
A lei Venezia vista dalla carta più che un pesce sembra «un ginocchio fratturato». E di Venezia si è ripromessa di non parlare nei libri perché, dice, «sono convinta che non esista cosa più volgare di aggiungere pagine sul luogo più librescamente citato»”.
Solo che poi qualcosa accade. Arriva a Venezia, trova posto solo dalle suore canossiane, si perde anche se si vergogna di questo clichè, si trova chiusa fuori di notte col mal di pancia che cresce. Telefona a un amico veneziano che la ospita, ma quando lei chiede di un medico, l’amico trova una soluzione surreale che è per lei un segno del destino: invece di portarla da un medico, le spiega che essendo italiana può servirsi del servizio sanitario, basta che prenda la residenza a Venezia. Così la conduce per uffici deserti, abitati da ombre e impiegati che leggono il giornale e in dieci minuti si trova cittadina veneziana e può andare gratuitamente dal medico. «Non solo» scrive. «Potei essere testimone di una Venezia invisibile e in via di estinzione: la Venezia vuota, umida e silenziosa degli uffici governativi. Se esiste ancora una Venezia tollerabile, è questa».
E come abbandonare una cittadinanza così guadagnata? Senza «nessuna crisi di identità» eccola residente permanente «di una delle città più letterarie, e non per la benedizione di una penna aggraziata, né per fedeltà delle muse,ma a causa di una terribile malattia della vescica: l’ignobile cistis bacteriana».
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








